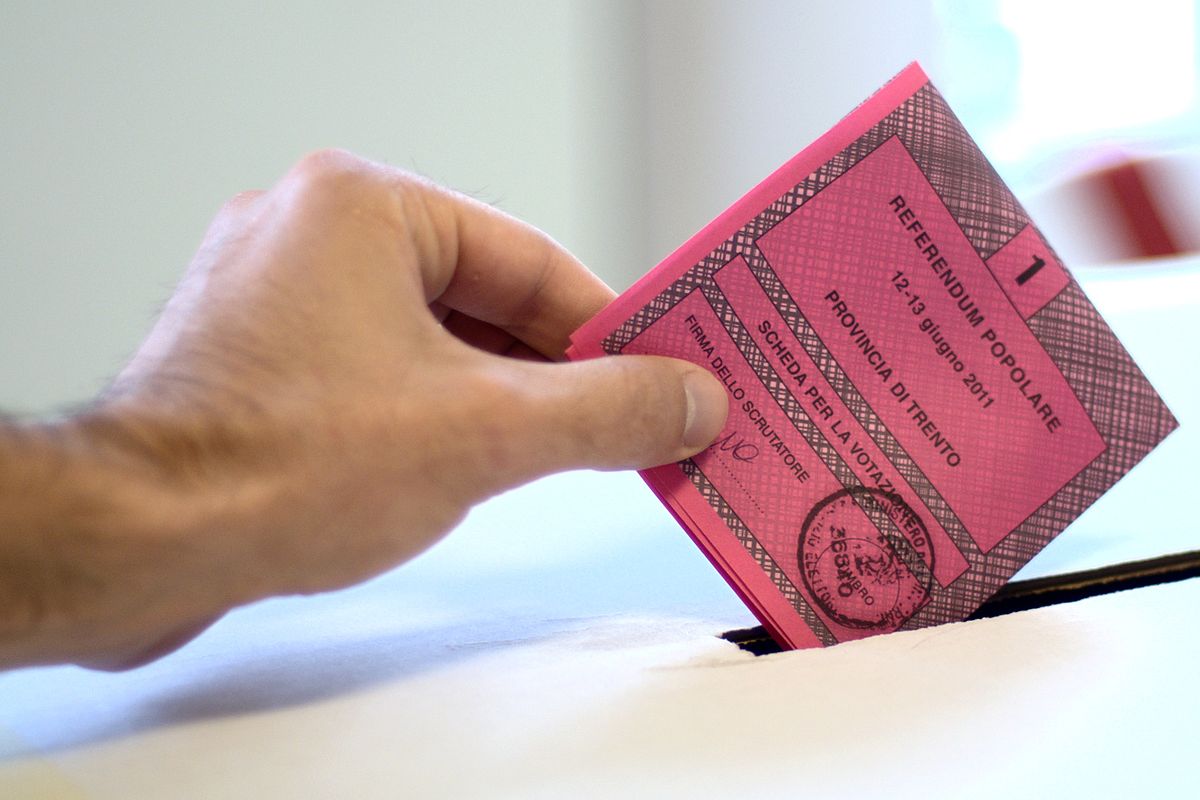Quando, nel giugno del 2014, il Consiglio Regionale del Veneto approvò le leggi n. 15 e n. 16, in materia di indizione di due referendum, uno sull’indipendenza del Veneto, l’altro su una maggiore autonomia politica e finanziaria della regione, pochi mass media veneti riportarono la notizia, concedendole una collocazione secondaria ed uno spazio assai limitato, mentre quelli nazionali tacquero quasi del tutto. Eppure l’evento avrebbe meritato ben altro interesse, visto che il massimo organo politico di una tra le regioni più importanti del Paese aveva preso una tale clamorosa iniziativa, chiedendo ai suoi cittadini di esprimersi sull’eventualità di una secessione.
Altrettanto silenzio, e forse ancora più grande, ha colpito la notizia della bocciatura, da parte della Corte costituzionale, delle due leggi regionali (ad eccezione della parte prevedente un referendum consultivo sulle “ulteriori forme di autonomia” tenutosi, com’è noto, il 22 ottobre 2017). Un silenzio assordante che, alla luce delle sconcertanti (ancorché non nuove) affermazioni contenute nella sentenza, affermazioni talora pure contraddittorie, la dice lunga sul sonno delle coscienze che avvolge coloro che dovrebbero essere le sentinelle della democrazia e coloro che, per la preparazione intellettuale e per il ruolo che ricoprono nella società civile, avrebbero il compito di analizzare l’attività del principale garante dei diritti fondamentali dei cittadini e di denunciarne le sue eventuali derive illiberali.
Con la legge regionale n. 16/2014, il Consiglio Regionale ha approvato l’indizione di un referendum con il quale viene proposto, ai propri residenti, il seguente quesito: vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana?
Con la legge regionale n. 15/2014, invece, sono stati rivolti ai veneti quesiti politicamente assai meno ambiziosi, come la volontà di avere maggiori margini di autonomia, di mantenere nella regione la gran parte dei tributi ivi riscossi e di ottenere il riconoscimento di uno statuto speciale.
Il governo Renzi, avendone titolo, ha impugnato queste leggi avanti la Corte costituzionale, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalità per una serie di motivi.
A chi non è particolarmente avvezzo alle tematiche giuridiche, converrà fornire alcune nozioni ed alcuni richiami normativi che gli consentiranno di entrare nel cuore della questione e di comprendere il senso dei ragionamenti che verranno svolti. Niente di particolarmente difficile: è bene non badare a quanti dicono che l’uomo comune non può entrare nel dibattito su molti temi che attengono alla vita istituzionale perché troppo tecnici. Alcuni magari lo saranno, ma non quello che qui ci interessa.
Quasi tutti sanno che la nostra Costituzione prevede il referendum abrogativo (art. 75), ma non quello propositivo. Si possono cancellare leggi o parti di leggi, mentre non si possono sottoporre a referendum proposte di nuove leggi o di revisione di quelle vigenti. Ma neppure il referendum abrogativo può interessare ogni tipo di leggi: l’art. 75 vieta di sottoporre a referendum le leggi di bilancio, tributarie e penali. A ben vedere, il referendum abrogativo è l’unico vero strumento di democrazia diretta previsto dal nostro ordinamento costituzionale.
Il referendum abrogativo, ove indetto e approvato dalla maggioranza dei votanti, va ad incidere direttamente sull’ordinamento giuridico, eliminando la norma o le norme che ne costituiscono l’oggetto.
Proprio perché il referendum abrogativo ha un’efficacia diretta sull’ordinamento giuridico, nel senso che lo può modificare senza l’intervento del Parlamento o del Governo, la legge costituzionale n. 1 del 1953 ha previsto che esso non possa essere tenuto se non passa il filtro della Corte costituzionale. In pratica, dopo la raccolta delle firme e prima di poter essere indetto, la Corte costituzionale ne vaglia la compatibilità con la Costituzione. L’intervento di carattere preventivo della Corte costituzionale è, in questo caso, del tutto logico perché, come detto, se approvato dagli elettori, il referendum provoca direttamente ed automaticamente una modifica dell’ordinamento giuridico. Visto che non genera norme, ma le distrugge, diventerebbe difficile prevedere un intervento successivo della Corte costituzionale.
Tutto ciò non avviene (o non dovrebbe avvenire) per i referendum strettamente consultivi come quelli che la Regione Veneto voleva promuovere.

Il referendum consultivo ha unicamente l’obiettivo di sondare l’opinione dei cittadini, dotati del potere di voto, con riguardo ad una determinata questione, da parte dell’organo rappresentativo che è espressione della comunità di tali cittadini.
Passando dal Veneto allo Stato nazionale, per quale motivo – ci si chiede – il Parlamento non potrebbe votare una legge con cui chiede, attraverso un referendum consultivo, l’opinione dei cittadini circa il mantenimento o l’abrogazione di una legge fiscale o di una legge penale?
Un simile referendum, anche se approvato, non avrebbe certo la forza di abrogare tale legge (questo effetto, come visto, è espressamente escluso dall’art. 75 Cost.), ma potrebbe dare – soprattutto in presenza di una consistente maggioranza – un’indicazione ai rappresentanti politici di quale sia la volontà dei cittadini. I parlamentari, a cui la Costituzione garantisce la tutela del divieto di mandato imperativo (art. 67), potranno valutare liberamente come procedere in ordine alla tematica portata davanti agli elettori e sulla quale questi ultimi si sono espressi.
Mettere sullo stesso piano il referendum capace di modificare l’ordinamento giuridico (come quello previsto nell’art. 75 Cost.) ed il referendum consultivo, frutto di un’eventuale decisione di un organo politico rappresentativo di una comunità di cittadini, è pertanto concettualmente, razionalmente e giuridicamente insostenibile. Eppure è quello che fa, da decenni, la Corte costituzionale.

Corre infatti l’esigenza di rilevare che, ad un’attenta lettura della sentenza qui commentata (per nulla brillante nel suo sviluppo logico) e dei precedenti giurisprudenziali in essa richiamati, l’argomento basato sull’unità e sull’indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 della Costituzione è stato usato dalla Corte come rafforzativo di un altro argomento da cui deriverebbe la prima preclusione al riconoscimento della legittimità della legge regionale veneta sul quesito dell’indipendenza. Ciò risulta con sufficiente chiarezza sia, come detto, dai richiami giurisprudenziali cui la Corte fa ricorso, sia dal fatto che anche la legge relativa ai referendum sull’autonomia fiscale e finanziaria del Veneto, nonché sull’attribuzione di uno statuto speciale, è stata ampiamente censurata benché non avesse alcuna finalità di rompere l’unità e l’indivisibilità della Repubblica.
Dice la Corte, nella sentenza in commento, che il referendum non è equiparabile ad uno spontaneo esercizio della libertà di pensiero. Piuttosto, il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all’intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto (come il referendum abrogativo previsto nell’art. 75), il referendum consultivo, sempre a detta della Corte, assolve una funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo.
Come da tali argomenti possa discendere la conclusione che un referendum consultivo sia di principio contrario alla Costituzione è francamente difficile da comprendere. Tutti possiamo essere d’accordo sul fatto che il referendum sia uno strumento di raccordo tra i cittadini e le istituzioni rappresentative. E dunque? In una repubblica democratica questo dovrebbe essere, semmai, un elemento positivo, un evento altamente auspicabile, a maggior ragione quando si tratta di questioni di particolare rilevanza. Tutto ciò senza paventare od ammettere alcuno scavalcamento del popolo rispetto ai suoi rappresentanti politici, che, tra l’altro, come detto, non sono tenuti ad alcun vincolo di mandato.
Va segnalato che la Corte, in altre occasioni, ha sostenuto espressamente che le Regioni possono assumere iniziative anche in tema di revisioni costituzionali (tra le tante, sentenze n. 256/1989, n. 496/2000 e n. 470/1992), ma tali iniziative devono maturare esclusivamente nell’ambito dei consigli regionali. Non è concepibile, a suo avviso, che il tutto sia condizionato da un referendum consultivo in cui il popolo esprime il suo parere in ordine ad una possibile iniziativa di revisione costituzionale. Nella sentenza n. 365/2007, richiamata nella decisione qui commentata, la Corte afferma che esisterebbe, nel nostro ordinamento costituzionale, «un’intensa istanza protettiva delle fonti superiori finalizzata a garantire la piena ed effettiva libertà della rappresentanza politico-parlamentare nell’esercizio dei supremi poteri normativi, che non può essere condizionata da atti e procedure formali non previsti nell’ordinamento costituzionale, seppure non giuridicamente vincolanti». Ma non basta. Nella sentenza n. 470/1992, sempre citata nella decisione oggetto della presente nota, la Corte dichiara a chiare lettere che un referendum consultivo va bloccato perché è necessario «evitare il rischio di influenzare negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello Stato».
Finalmente, mettendo insieme i passaggi contenuti in più sentenze, emerge in tutta la sua spaventosa chiarezza il pensiero della nostra Corte costituzionale: le Regioni possono promuovere iniziative volte a modificare la Costituzione, seguendo la procedura ivi prevista, ma non sia mai che il popolo (od una frazione di esso), possa essere consultato su tale argomento perché ciò potrebbe in qualche modo condizionare il proseguimento o l’abbandono dell’iniziativa da parte dei suoi rappresentanti politici. E ciò va evitato perché il popolo potrebbe influenzare negativamente i suoi rappresentanti nel momento in cui questi assumono le loro determinazioni, nella loro veste di unici titolati a revisionare la Carta costituzionale! Tale teorizzazione, in verità, dovrebbe scandalizzare tutti i cittadini e farli seriamente dubitare della democraticità del sistema in cui essi vivono. Lascia increduli che l’organo che dovrebbe tutelare la democrazia e la libertà degli italiani possa giungere a fare simili affermazioni ed utilizzarle come base teorica per impedire l’espressione della volontà popolare. Ed è ancor più sorprendente che chi dovrebbe essere la sentinella della democrazia e coloro che sono i depositari della conoscenza giuridica girino il volto da un’altra parte e facciano finta di nulla. Qui non è in discussione l’indipendenza o l’autonomia del Veneto, questione del tutto contingente, qui sono in discussione gli stessi fondamenti dello Stato e della sovranità popolare. Per questo abbiamo detto, all’inizio di questa nota, che ciò che colpisce di più è il silenzio assordante, il sonno delle coscienze che intorpidisce l’intero Paese e che lo conduce verso un inesorabile declino.
Così ragionando, la Corte dimostra inoltre di vivere lontano mille miglia dalla realtà. Infatti, è sotto gli occhi di tutti (e crediamo che nessun lo possa negare) come, soprattutto negli ultimi anni, si sia creato uno scollamento tra i cittadini e gli organi politici, i primi invocanti profonde riforme istituzionali ed economiche, i secondi arroccati in difesa dei propri privilegi e delle posizioni di potere dei partiti. Tale vistoso, innegabile scollamento dimostra che i rappresentanti politici sono normalmente refrattari di fronte alle istanze provenienti dal popolo e ben lontani dall’esserne condizionati. Guardiamo, tra l’altro, al caso del referendum abrogativo di circa vent’anni fa sul finanziamento pubblico dei partiti. La maggioranza degli italiani, oltre il 90% (!), ha bocciato la legge e il Parlamento si è subito affrettato a farne un’altra, per continuare a garantire un enorme flusso di denaro pubblico ai partiti, cambiando semplicemente la forma e parlando di rimborsi spese, come se la sostanza non fosse sempre quella. Davanti a simili, frequenti prove di indifferenza verso la volontà popolare, suona quasi ironica l’idea della Corte costituzionale che serva una barriera a protezione dell’autonomia decisionale dei rappresentanti politici.
In definitiva, la Corte sbaglia sotto diversi profili: in diritto, perché mette sullo stesso piano il referendum che incide direttamente sull’ordinamento giuridico ed il referendum (semplicemente) consultivo, quando le rispettive nature e i rispettivi effetti sull’ordinamento non sono – neppure minimamente – confrontabili, finendo quindi per valutare in modo eguale due istituti completamente differenti; in fatto (per così dire), perché, nella valutazione della legittimità di un referendum consultivo, parte da un presupposto manifestamente infondato, ossia la sua capacità di condizionare le scelte degli organi politici eletti. Non solo. La Corte si muove in una visione distorta e fuorviante dello spirito costituzionale: il fatto che la Costituzione limiti l’esercizio diretto della sovranità popolare al referendum abrogativo di cui all’art. 75 non significa affatto che la Costituzione rifiuti od impedisca altre forme di manifestazione della volontà popolare. Essa stabilisce in quali precise e circoscritte situazioni tale volontà sia in grado di produrre effetti sull’ordinamento giuridico, ma non vieta né prende in considerazione le ipotesi in cui un organo democraticamente eletto decida, in piena libertà e secondo le ordinarie procedure deliberative, di conoscere l’opinione della comunità di cui è espressione. Opinione che potrà essere liberamente valutata dall’organo promotore, senza che quest’ultimo ne sia giuridicamente vincolato. Ovviamente lo strumento conoscitivo più attendibile è proprio quello del referendum in quanto procedura ordinata e sottoposta a vigilanza pubblica in grado di conferire garanzia di trasparenza e di libertà. Appare quindi fortemente criticabile la posizione più volte assunta ed ultimamente ribadita dalla Corte costituzionale, la quale si attribuisce una sorta di compito di “polizia” preventiva che la Costituzione non le riconosce nei casi come quello in discussione e che lascia una brutta sensazione di cose già tristemente vissute in altre epoche ed in altri regimi.

Per la Consulta, non solo la legge veneta avente per oggetto il referendum sull’indipendenza e sull’autonomia speciale non sarebbe ammissibile in forza del principio sopra esposto (in verità, come detto, principio di pura “invenzione” della Corte), ma detta legge suggerirebbe addirittura sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost., principi che – a dire della stessa Consulta – sono sottratti persino al potere di revisione costituzionale.
Ora, è a tutti noto che l’unico aspetto che la Costituzione impedisce espressamente di modificare è la forma repubblicana dello Stato (art. 139). Un’interpretazione letterale della Costituzione porterebbe quindi ad affermare che tutti gli altri articoli della stessa siano modificabili e revisionabili, compreso il citato art. 5.
Tutti possiamo peraltro convenire sul fatto che esistano dei limiti impliciti al potere di intervenire sulle previsioni costituzionali. Un Parlamento che, pur rispettando formalmente le procedure previste dall’art. 138 per la revisione della Costituzione, volesse cancellare dal testo il diritto di libertà di pensiero e di opinione, il diritto alla libertà di stampa o di pacifica associazione o il diritto di proprietà, si porrebbe in palese contrasto con il fine ed i fondamenti della Costituzione stessa, per cui la relativa legge di modifica dovrebbe essere dichiarata incostituzionale.
La vera questione, tuttavia, non è tanto se sia vietato cambiare certe disposizioni della Costituzione, quanto, piuttosto, che non si possono annullare o restringere irragionevolmente i diritti fondamentali della persona. Anche i più conservatori tra gli attuali giuristi alla fine sono costretti ad ammettere che la Repubblica, per quanto riguarda i diritti fondamentali, non li istituisce, ma li dichiara. Non a caso, infatti, l’art. 2 dice che la Repubblica “riconosce” i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Li “riconosce” perché pre-esistono, esistono prima di essa, anzi lo Stato e la Costituzione sono stati creati in funzione della garanzia e della protezione di tali diritti.
Sono pertanto i diritti fondamentali (od inviolabili, che si voglia dire) che non possono essere negati o compressi, non le singole disposizioni costituzionali in quanto tali.
Al di fuori di questo nucleo essenziale, tutto il resto della Costituzione può essere oggetto di modifica e di revisione, compreso, come detto, l’art. 5. Opinare altrimenti significa permettere l’apertura di una voragine senza fondo, perché, a seconda dell’idea o dell’ideologia del “costituzionalista” di turno (compreso il giudice costituzionale), si potrebbero individuare, in modo assolutamente discrezionale, per non dire arbitrario, aspetti ritenuti sottratti al potere di revisione costituzionale.
In proposito, nel corso degli anni, se ne sono sentite di tutti i generi, anche da parte di persone considerate autorevoli: per alcuni la Costituzione non potrebbe essere modificata per trasformare l’Italia in uno Stato presidenziale, per altri non si potrebbero rivedere le norme sul governo della magistratura, per altri ancora non si potrebbe introdurre una forma federale dello Stato. Insomma, una congerie di opinioni priva di una seria base sia politica sia giuridica che però genera incertezza e disorientamento, soprattutto nei cittadini, che guardano ancora con rispetto a questi sedicenti soloni. L’effetto di tutta questa grande confusione è rendere ancora più farraginoso il dibattito sull’assoluta ed imprescindibile necessità di emendare una Costituzione che ha rivelato nel corso del tempo tutti i suoi limiti. Si tratta senza dubbio di una confusione programmata, cercata e perseguita da parte di coloro che vogliono il mantenimento dello status quo.
In altre parole, nel momento in cui, come fa la nostra Corte costituzionale, si afferma che vi sarebbero delle disposizioni costituzionali non modificabili in aggiunta a quella contenuta nell’art. 139, sebbene non attinenti ai diritti fondamentali dell’individuo, allora si finisce per legittimare più o meno qualsiasi opinione in ordine a quali articoli, a quali strutture, a quali parti siano sottratti al potere di revisione costituzionale. La Consulta non può (o, meglio, non potrebbe) travalicare quelli che sono i confini del suo ruolo e dimenticare lo spirito che sta alla base della Costituzione.
Per tali ragioni, utilizzando i normali canoni interpretativi, si deve giungere all’opposta conclusione, ossia che l’art. 5 della Costituzione, in quanto non relativo ai diritti fondamentali dell’individuo, è tranquillamente modificabile ricorrendo alle procedure previste dall’art. 138.
Vale la pena segnalare che, qualche mese dopo la pubblicazione della sentenza qui commentata, è stato nominato un nuovo giudice costituzionale, nella persona del prof. Franco Modugno. Qualche anno fa, il prof. Modugno ha scritto, seminando un po’ di stupore e – possiamo dire – anche un po’ di scandalo tra i suoi colleghi, alcune pagine sulla questione della valenza dell’art. 5 Cost. rispetto alle istanze indipendentiste provenienti da qualche area dell’Italia. Il prof. Modugno ha detto di non vedere nel predetto articolo costituzionale un insormontabile ostacolo per un’eventuale legge costituzionale che preveda e disciplini le condizioni, i modi e le forme per eventuali separazioni, secessioni, perdite o diminuzioni dell’entità territoriale, purché preveda altresì le necessarie compensazioni (di natura anche non territoriale, per es. finanziaria), alla perdita o diminuzione del valore complessivo del bene-territorio.
L’occasione ci conduce ad allargare la prospettiva ed a chiederci se sia accettabile che, in un testo costituzionale moderno e democratico, esistano delle disposizioni che siano esplicitamente od implicitamente non revisionabili.
Parliamo ovviamente sempre di disposizioni che non hanno ad oggetto il riconoscimento di diritti e libertà fondamentali dell’individuo e la loro tutela. E’ opportuno ripetere che non sono tanto le disposizioni che non possono essere modificate, ma sono i diritti e le libertà di cui parlano che non possono essere ignorati, calpestati o irragionevolmente limitati. Se così non fosse la Costituzione smetterebbe di essere tale e perderebbe la sua ragione d’esistere.
Ma fuori da tale stretto ambito, perché dovrebbero esistere disposizioni costituzionali non modificabili? Chi può arrogarsi il diritto di impedire ad una comunità, ad una generazione che vive in un determinato momento storico di decidere pienamente e liberamente la propria organizzazione e le regole di convivenza comune? Nessuno finora ha mai fornito una risposta convincente a tali domande.
Con il massimo rispetto dovuto a coloro che hanno stilato la nostra Costituzione, non riteniamo che essi avessero il potere di farlo. Erano uomini normalissimi, usciti da una durissima guerra. Hanno raggiunto un faticoso accordo su un testo costituzionale, hanno compiuto il loro dovere, hanno visto nel sistema disegnato dalla Costituzione un buon sistema in cui vivere. Sono passate più generazioni da allora, molte cose in Italia e nel mondo sono cambiate: perché il popolo vivente non può guardare allo Stato, alle istituzioni, agli ambiti comuni, ai fondamenti della convivenza in modo diverso da allora? Con quale autorità i costituenti hanno inserito disposizioni che i loro futuri discendenti non potrebbero mutare, anche se volessero farlo? Come si può pretendere che tali disposizioni siano accettate come un dogma da questa generazione e dalle generazioni future? Qual è la natura e quali sono i fondamenti di questo vincolo preteso come eterno?
Sono domande da fare a coloro che – come la nostra Corte costituzionale, ma non solo – sostengono con sicurezza, talora con insopportabile arroganza, l’impossibilità “oggettiva” di cercare ed adottare modelli alternativi a quello dello Stato attuale.
Se il popolo italiano, ad un certo punto, ritenesse che fosse preferibile la forma monarchica piuttosto che quella repubblicana, perché non potrebbe farlo seguendo una determinata, formale procedura di revisione di una parte della Costituzione? Forse il Regno Unito, la Svezia, la Danimarca, l’Olanda sono Stati dove non sono garantiti ampi diritti e libertà? Sono forse Paesi peggio governati del nostro? Perché dunque impedire ad un popolo di decidere del proprio destino e di organizzare, secondo le proprie convinzioni ed esigenze, lo Stato in cui vivere? Non si capisce, in verità, per quale “superiore” ragione simili prospettazioni dovrebbero essere considerate fenomeni di sovversione dell’ordinamento, tali da dover essere contrastate dall’ordinamento stesso.
Il medesimo discorso può essere fatto per l’eventuale libera decisione di una parte della comunità nazionale di distaccarsi dalla stessa. Anche in questo caso, se andiamo all’origine delle cose senza lasciarci disorientare da vacue teorizzazioni, non c’è un fondato e razionale motivo per cui una tale separazione non sia lecita, possibile e realizzabile in modo pacifico.
Nulla può limitare o comprimere la libertà di un popolo, che si ritiene tale, di decidere il proprio destino, di organizzare il proprio modo di vivere e di convivere all’interno di un sistema condiviso di regole e valori. Eventuali disposizioni, anche di rango costituzionale, di senso contrario, seppure esistenti, non potrebbero essere considerate vincolanti, in quanto violerebbero un diritto fondamentale dei singoli cittadini e dell’intero corpo da essi formato, diritto pre-esistente, che prevale sopra ogni diversa statuizione.
Spesso politici, giuristi e commentatori vari si richiamano insistentemente ai principi ed alle conquiste dell’Illuminismo e della rivoluzione francese.
Vale la pena quindi ricordare che Rousseau rifiutava l’idea che la volontà generale potesse vincolare per il futuro e rigettava l’idea della dialettica dei vivi e dei morti, l’idea cioè che le generazioni future siano vincolante dalle decisioni prese nel passato.
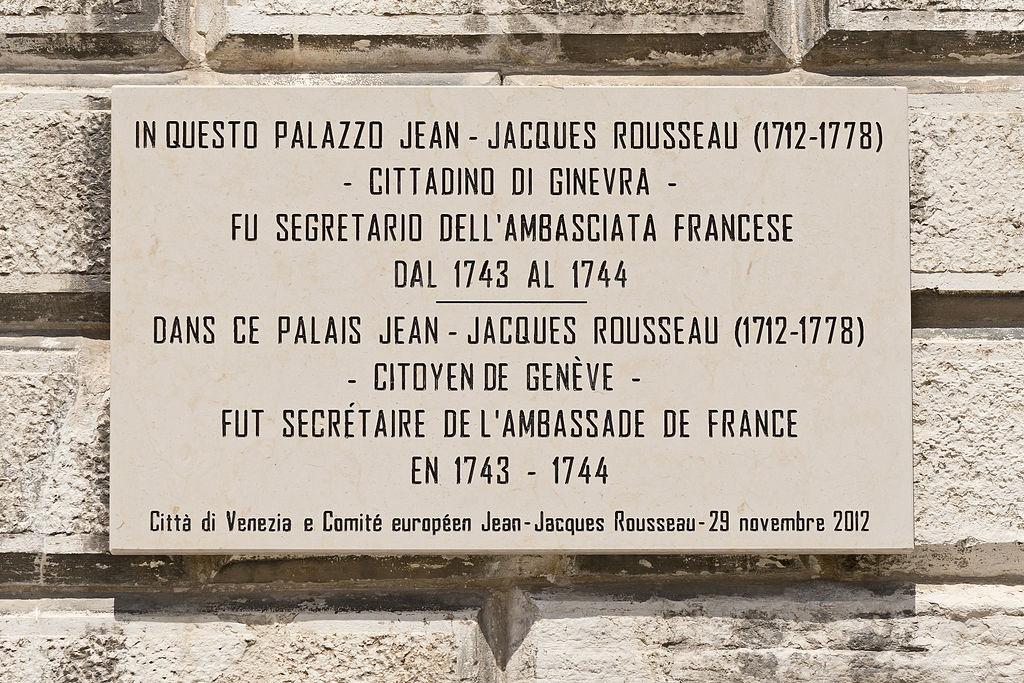
Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 24 giugno 1793, l’art. 28 stabiliva esplicitamente che il popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la sua costituzione e che una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Questa parte della Dichiarazione non venne più riprodotta nelle successive versioni perché nel frattempo era prevalsa una visione meno favorevole alle manifestazioni di democrazia diretta, con l’aumento dell’influenza dei teorici della democrazia rappresentativa e della politica governata da partiti e da gruppi elitari. Tuttavia, è particolarmente interessante notare che la predetta
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino precedeva l’Atto costituzionale, portante la stessa data, nel quale, all’art. 1, si sanciva che «La Repubblica francese è una ed indivisibile», formulazione copiata poi di sana pianta dai costituenti italiani dell’ultimo dopoguerra e collocata nell’art. 5 dell’attuale Costituzione. Sol che, come detto, tale previsione normativa era subordinata dalla Dichiarazione dei diritti ed in linea di principio rivedibile da parte del popolo sovrano delle future generazioni.
Sul versante del costituzionalismo anglosassone, converrà rammentare le posizioni più volte espresse da Thomas Jefferson, l’autore dell’altissima dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, secondo le quali i morti non possono vincolare i vivi e le decisioni dei primi possono essere pienamente riviste dai secondi. Nella lettera, datata il 12 luglio 1816 ed indirizzata a Samuel Kercheval, egli scrisse: «Alcuni guardano alle costituzioni con sacra riverenza e le considerano come l’Arca dell’alleanza, troppo sacra per essere toccata. Attribuisco agli uomini delle epoche passate una saggezza più che umana e ritengono che ciò che essi fecero non possa essere migliorato. Ho conosciuto quei tempi: in essi ho vissuto ed agito. Meritano di essere ricordati con gratitudine da parte del nostro Paese. Erano assai simili al presente, ma non avevano l’esperienza di oggi (…). Non sono certamente un fautore di frequenti innovazioni nelle leggi e nelle costituzioni. Penso che sia preferibile sopportarne le imperfezioni più leggere: una volta riconosciutele, infatti, ci adattiamo ad esse e troviamo sistemi pratici per correggerne gli effetti negativi. So anche, però, che le leggi e le istituzioni devono andare di pari passo con i progressi compiuti dalla mente umana (…). Ciascuna generazione ha la stessa indipendenza di quella che l’ha preceduta, così come questa era indipendente rispetto a quelle venute prima di lei. Ciascuna ha quindi diritto di scegliere il tipo di governo che ritiene più adatto a promuovere la propria felicità e, di conseguenza, di cambiare la situazione in cui si trova, che è ereditata dai suoi predecessori».
Pur antagonista ed avversario politico di Jefferson, in quanto convinto sostenitore di un potere federale forte e per certi versi invasivo, Alexander Hamilton, altro padre fondatore degli Stati Uniti d’America, concordava sul fatto che i cittadini «possono modificare o abolire la Costituzione ogniqualvolta la ritengono non coincidente con la propria felicità» (Federalist Papers, n. 78).
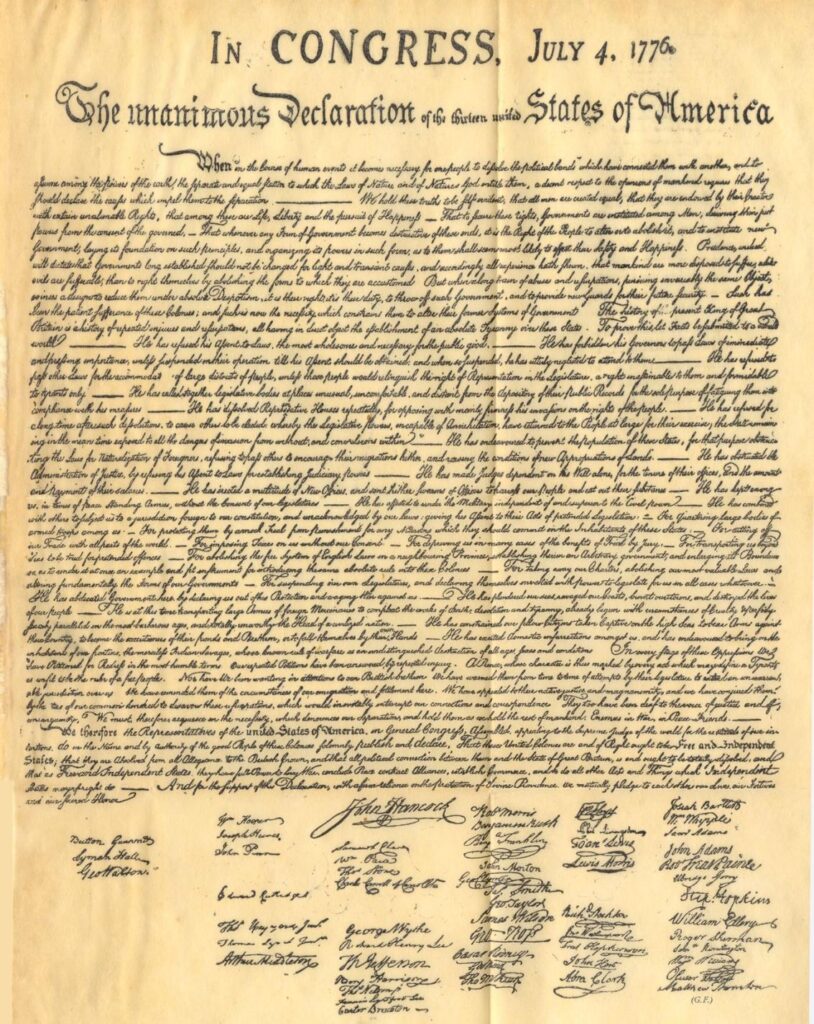
Thomas Paine, famoso pensatore e politico anglo-americano, sempre in prima linea nel combattere l’assolutismo e l’oppressione dei poteri costituiti, diceva: «non vi fu mai né mai vi sarà, né potrà mai esservi un parlamento od una categoria di uomini o una generazione, in nessun Paese, che abbia il diritto od il potere di vincolare e disporre della discendenza fino alla fine dei tempi, o di stabilire per sempre come il mondo debba essere governato o chi debba governarlo; e pertanto tutte le clausole, gli atti, le dichiarazioni mediante cui i loro autori pretendono di fare ciò che non hanno né il diritto né il potere di fare, o di far eseguire, sono in se stesse irrite o nulle. Ogni età e generazione deve essere libera di agire autonomamente in ogni caso, come le età e le generazioni che la precedettero. La vana presunzione di governare dalla tomba è la più ridicola ed oltraggiosa di tutte le tirannidi» (ne I diritti dell’uomo).

Chi può, nel pieno della propria onestà intellettuale, non condividere le parole di questi grandi pensatori? Sono, in verità, riflessioni di una semplicità che non lascia scampo e che sono facilmente comprensibili a chiunque e per questa ragione assai pericolose per i custodi delle istituzioni politiche. Solo cieche ideologie o meno nobili interessi egoistici potrebbero contrastare una simile visione delle cose e della vita. E’ curioso che in un’epoca in cui l’uomo ha cacciato Dio dalla scena sociale, politica ed economica, in cui i comandamenti divini sono validi solo se confermati dal Parlamento, in cui è stata riaffermata l’autonomia del diritto dalla morale, in cui è stato messo in discussione il millenario dogma dell’infallibilità del Papa, si finisce per creare e venerare dogmi assoluti come l’unità dello Stato o la Costituzione (o parti di essa), in una sorta di idolatria pagana che è in perfetta contraddizione con i valori di fondo della democrazia moderna. Aveva proprio ragione Gilbert K. Chesterton, il quale, con la consueta arguzia, diceva che da quando l’uomo ha smesso di credere in Dio non è vero che non crede più a nulla: il guaio è che ha preso a credere a tutto.
Articolo scritto da Roberto Baggio